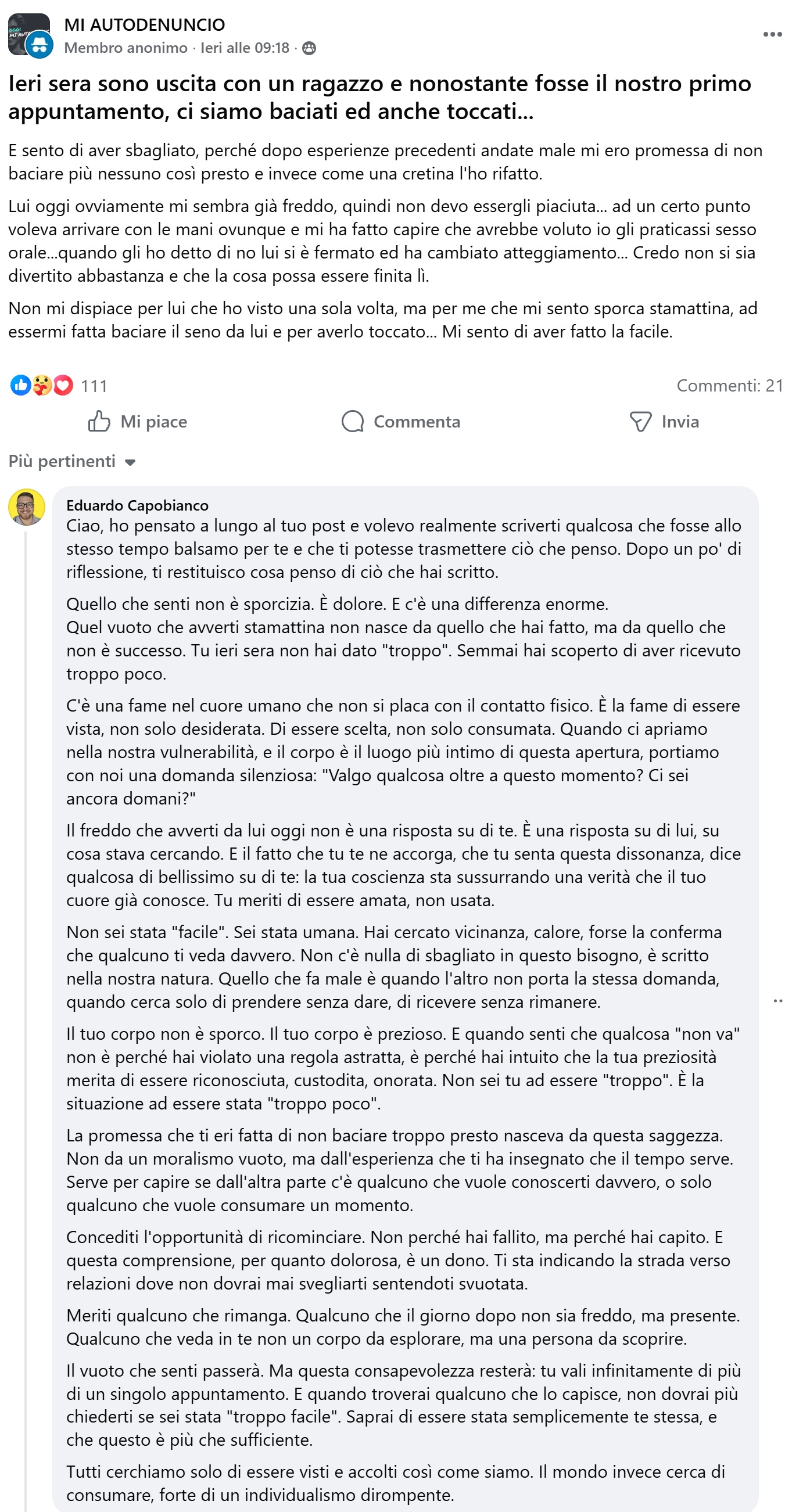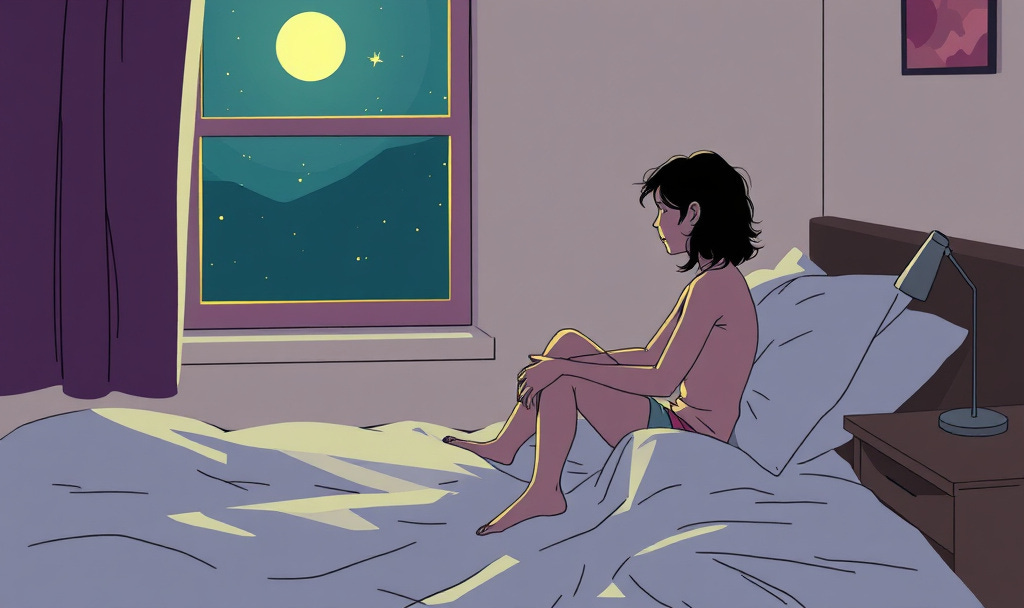#6 Il vuoto di chi si lascia consumare
Storia di una fame che nessun corpo può saziare
Sono mesi che non scrivo. Non per mancanza di cose da dire, ma forse perché certe urgenze hanno bisogno di maturare nel silenzio prima di trovare parole. Poi ieri, navigando distrattamente su Facebook, ho letto un post. Una ragazza che si autodenunciava, che si sentiva sporca. E ho sentito la necessità di scrivere il mio punto di vista. Non perché abbia soluzioni da vendere o verità da impacchettare, ma perché quello che ho letto parla di qualcosa che è diventato sempre più urgente: la necessità di amore in un mondo che ci ha insegnato a cercarlo nei posti sbagliati.
Ho letto il suo post. Poi ho letto i commenti. E in quei commenti ho visto il mondo che risponde con le sue medicine sbagliate, quelle che curano la febbre senza accorgersi dell’infezione.
Quando le risposte mancano il bersaglio
C’era chi le diceva: “Ti senti in colpa per il maschilismo, ti hanno insegnato che non si fa così”. Come se il suo dolore fosse solo un condizionamento culturale da superare, una catena mentale da spezzare. Ma questa risposta nega la sua esperienza reale. Lei non si sente male perché ha infranto una regola morale scritta da qualche patriarca del passato. Si sente male perché ha cercato calore e ha trovato freddo. Perché il giorno dopo lui non c’era più. Quella sensazione di vuoto non è un fantasma ideologico - è una percezione autentica che qualcosa di essenziale mancava.
C’era chi le diceva: “Non hai fatto nulla di male, lui si è fermato quando glielo hai chiesto”. Vero. Inutilmente vero. Perché il suo dolore non nasce dall’aver infranto una regola, ma dall’aver scoperto che dietro quel contatto non c’era nessuno che volesse restare. Lui si è fermato, certo. Ma il giorno dopo è sparito. E in quello sparire c’è tutta la verità che lei aveva già intuito quella sera: non era vista, era attraversata.
C’era chi le diceva: “Divertiti, fai quello che vuoi, è il tuo piacere che conta”. Ma lei ha fatto quello che voleva - e ora sta male. Perché volere qualcosa non significa che quella cosa ti nutrirà. Puoi avere sete e bere acqua salata, ma la sete resta. Anzi, aumenta.
Tutti questi commenti, per quanto diversi nei toni, convergono sullo stesso errore fondamentale: trattano il sintomo ignorando la malattia. Nessuno le sta chiedendo la domanda vera: perché quel vuoto? Perché quella fame che nessun contatto fisico sembra riuscire a saziare?
Il vuoto come bussola
Quella ragazza non è un’eccezione. È la norma mascherata da mille volti diversi, da mille post anonimi su mille gruppi Facebook. Il punto non è se ha “sbagliato” o no. Il punto è: perché così tante persone cercano connessione nei corpi e restano con le mani vuote? Perché quella corsa verso l’intimità fisica lascia così spesso un senso di abbandono?
C’è una parola che dovremmo recuperare: custodirsi. Non nel senso moralista del “preservati per il matrimonio” o del “non fare così presto”. Ma nel senso profondo di riconoscere che tu vali infinitamente di più di un momento. Che il tuo corpo non è un territorio da esplorare per qualcuno di passaggio, ma un luogo sacro dove puoi scegliere chi far entrare. E quando dico sacro non parlo di una sacralità religiosa astratta - parlo del fatto concreto che quando ti apri nella vulnerabilità, quando porti qualcuno nel luogo più intimo di te, stai compiendo un atto di fiducia totale.
“Ci sei ancora domani?” - questa domanda che lei non ha osato fare ad alta voce, ma che vibrava in ogni sua cellula quella sera, è la domanda che rivela tutto. Non cercava un orgasmo, cercava qualcuno che restasse. Non cercava un’esperienza, cercava una presenza. E quando hai capito che dall’altra parte c’era solo uno che cercava di prendere senza dare, il freddo è arrivato. Non come giudizio morale, ma come verità che il tuo corpo e la tua anima stavano registrando insieme.
La diagnosi sbagliata di una società malata
Il problema è che la società ci dà due risposte sbagliate, apparentemente opposte ma ugualmente inutili.
Da una parte c’è il moralismo sterile. “Non fare sesso troppo presto”. “Proteggiti”. “Fai attenzione”. Come se il problema fosse il timing o la precauzione fisica. Ma questa morale non chiede mai: perché quella fame? Perché quella solitudine? Si limita a dire “aspetta” senza mai spiegare cosa stai aspettando, o perché ne vale la pena. È una regola senza ragione, un “no” senza un “sì” più grande.
Dall’altra parte c’è il permissivismo vuoto. “Divertiti”. “È il tuo corpo, fai quello che vuoi”. “La sessualità è liberazione”. E quando poi il vuoto arriva, quando quella libertà tanto sbandierata ti lascia più sola di prima, ecco l’altra risposta pronta: “È maschilismo interiorizzato”. Come se la soluzione fosse sempre più libertà, sempre più disinibizione, sempre più autonomia. Ma l’autonomia da cosa? Dalla tua stessa fame di essere vista?
Nessuna delle due risposte centra il problema vero. Perché il problema non è quanto velocemente vai a letto con qualcuno, o quanto sei liberata dai condizionamenti. Il problema è che viviamo in una società che ci spinge verso l’intimità fisica ma non costruisce più strutture dove le persone possano incontrarsi davvero. Ci hanno detto “fate quello che volete” ma non ci hanno insegnato cosa desiderare davvero.
L’individualismo galoppante ha divorato la comunità. Una volta c’erano luoghi di incontro ripetuto - il bar dove andavi ogni settimana e vedevi le stesse facce, l’associazione di quartiere, il circolo, la parrocchia per chi ci andava. Luoghi dove il tempo poteva fare il suo lavoro lento, dove potevi conoscere qualcuno non in una sera ma in mesi di piccole conversazioni. Ora tutto questo è collassato. Restano solo i luoghi di consumo: discoteche, locali, app. Ma senza tempo ripetuto non c’è conoscenza vera, c’è solo la fretta di arrivare al contatto prima che l’altro sparisca.
E così quella fame di essere visti, di essere scelti non per un momento ma per un cammino, resta insoddisfatta. E ci sentiamo sporchi non perché abbiamo fatto qualcosa di male, ma perché abbiamo scoperto di valere infinitamente di più di quello che ci è stato offerto.
La medicina che non osiamo nominare
Viviamo nel paradosso più stridente della storia umana. L’epoca della massima liberazione sessuale coincide con la massima solitudine emotiva. I corpi non sono mai stati così disponibili, eppure le persone non sono mai state così assenti. I giovani hanno teoricamente più opportunità di incontro che mai, eppure i dati ci dicono che fanno meno sesso delle generazioni precedenti. Perché? Perché forse hanno capito, più lucidamente di quanto sappiamo ammettere, che l’offerta del mondo è truccata. Che dietro quella disponibilità immediata c’è un vuoto che costa troppo.
Prendiamo Tinder. Un’app che ha trasformato l’incontro in un mercato di corpi, dove scorri profili come prodotti in un catalogo. Ogni swipe ti dice che c’è sempre un’opzione migliore, che non devi fermarti, che domani potrebbero esserci dieci profili nuovi. E così uccidi la capacità di vedere davvero la persona davanti a te. Perché vedere davvero richiede tempo, richiede scelta, richiede rinuncia. Ma in un mercato infinito, rinunciare sembra stupido.
E poi c’è la gamification della vulnerabilità. Tinder trasforma l’incontro in un gioco di statistiche. Quanti match? Quante conversazioni? Quanto velocemente si passa al fisico? Ma l’intimità vera non ha niente a che fare con questo. L’intimità è rischio, è tempo, è la lentezza di scoprire l’altro strato dopo strato. L’intimità vera è quando “ci sei ancora domani?” non è più una domanda ansiosa ma una certezza silenziosa. È quando puoi mostrarti fragile senza temere che l’altro sparisca. È quando l’altro ti vede non come corpo da esplorare ma come persona da scoprire, giorno dopo giorno.
E poi c’è qualcosa di ancora più sottile: il consumo di noi stessi. Per “vincere” in questo mercato, devi presentare una versione impacchettata di te. La foto giusta, la bio accattivante, la battuta al momento giusto. Ogni match che non si concretizza è un pezzo di autostima che se ne va. Ogni conversazione che muore è un frammento di te che resta appeso nel vuoto digitale.
Gli antichi ebrei avevano una parola per questo: Galah. Il velo. Ma Galah ha una doppia valenza bellissima - è il velo che delimita un limite, ma è anche lo svelamento. Velarsi per potersi svelare davvero. Perché solo quando ti custodisci, quando riconosci che c’è un confine sacro in te, puoi poi scegliere consapevolmente di far entrare qualcuno. E quello svelamento diventa dono, non consumo. Diventa incontro, non attraversamento. In un altro articolo (che ti condivido nel bottone qui sotto) ho parlato di come questo confine non sia una chiusura ma la condizione stessa della vera apertura - perché senza limite non c’è dono, c’è solo presa.
Ma abbiamo perso anche il linguaggio per dirlo. Non sappiamo più parlare di desiderio profondo. Abbiamo solo due registri: il linguaggio del consumo (”mi piace”, “ci sto”, “me lo farei”) o il linguaggio del moralismo (”è sbagliato”, “non si fa così”). Ma il linguaggio del desiderio autentico - quello che dice “voglio essere visto nella mia interezza”, “voglio qualcuno che resti anche domani”, “voglio donarmi non consumarmi” - ci suona ridicolo. Fuori moda. Naïve.
E così restiamo sospesi tra una libertà che ci svuota e una morale che ci imprigiona, senza avere più parole per nominare quello che davvero cerchiamo.
Il balsamo che serve
Non ho ricette facili. Non posso dire a quella ragazza “ecco cosa devi fare” perché non sono io a dover risolvere la sua vita. Ma posso dire questo: quel vuoto che senti non è colpa morale. È fame mal nutrita. È la tua anima che ti sta dicendo una verità che il mondo cerca di soffocare: tu meriti qualcuno che ti veda interamente. Qualcuno per cui tu sia presenza, non passaggio. Qualcuno che il giorno dopo non solo sia ancora lì, ma abbia voglia di conoscerti di più, non di meno.
La medicina giusta non è più moralismo sui comportamenti. È costruire strutture - dentro e fuori di noi - dove le persone possano incontrarsi davvero. Dove la vulnerabilità sia onorata, non sfruttata. Dove il tempo possa fare il suo lavoro lento di conoscenza. Dove “ci sei ancora domani?” sia una certezza, non un’ansia.
Forse inizia dal rifiutarsi di giocare al gioco truccato. Dal riconoscere che quella fame che senti è santa, è vera, e merita di essere saziata con pane vero, non con le briciole che il mondo ti offre scambiandole per banchetto.
Forse inizia dal ritrovare le parole per dire “voglio essere vista”, senza vergogna. Perché in quella frase apparentemente ingenua c’è tutta la dignità che ti spetta. C’è tutta la verità che il freddo dell’altro quella sera ti stava rivelando.
E forse inizia anche dal perdonarti. Non perché hai sbagliato, ma perché hai cercato amore nei modi che il mondo ti ha insegnato. E ora stai scoprendo che quei modi non bastano. E questa scoperta, per quanto dolorosa, è saggezza. Non sei stata “facile”. Sei stata umana. Hai cercato vicinanza, calore, la conferma che qualcuno ti vedesse davvero.
Non c’è nulla di sporco in questo bisogno. È scritto nella nostra natura. Quello che è sporco è un sistema che ti spinge verso l’intimità promettendoti pienezza, per poi lasciarti più vuota di prima e dirti che il problema sei tu.
Il tuo corpo non è sporco. Il tuo corpo è prezioso. E quando senti quel freddo, quella dissonanza, quella voce che dice “qualcosa non va” - quella non è la voce del maschilismo o della repressione. È la voce più vera che hai, quella che riconosce quando sei stata vista davvero e quando sei stata solo attraversata.
Ascoltala. Merita di essere ascoltata. Perché ti sta indicando la strada verso relazioni dove non dovrai mai più chiederti, nel buio della notte, se l’altro ci sarà ancora domani.